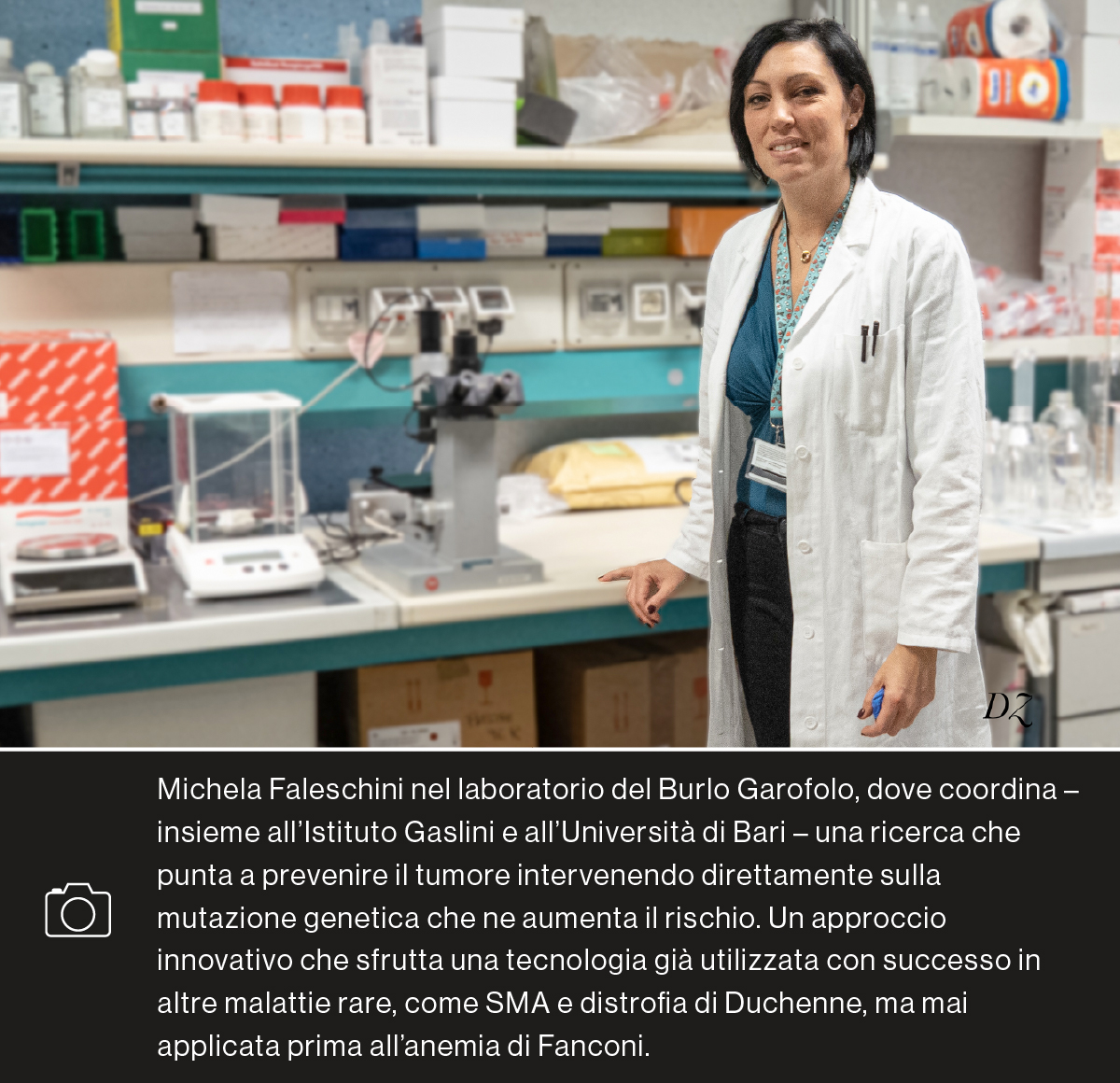Una malattia genetica rara, ma non per questo meno urgente. E se una cura ancora non esiste, forse si può costruire pezzo per pezzo. Come si ricuce un RNA difettoso.
Michela Faleschini, ricercatrice dell'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste, parte da qui: da un piccolo difetto nel meccanismo che ripara il DNA. Il progetto che le è valso un My First AIRC Grant, finanziamento quinquennale della Fondazione AIRC, mira a sviluppare una terapia farmacologica mirata per i pazienti con anemia di Fanconi.
Fino a pochi decenni fa questa malattia portava alla morte per insufficienza midollare. Oggi, grazie ai progressi nei trapianti di cellule staminali, molti pazienti superano i quarant’anni. Un traguardo importante, che però ha cambiato lo scenario clinico: la causa di morte principale non è più l’insufficienza midollare, ma lo sviluppo di tumori, soprattutto del cavo orale, che colpiscono fino al 60% dei pazienti adulti.
È su questo nuovo fronte che si concentra la ricerca coordinata dal Burlo Garofolo insieme al Gaslini e all’Università di Bari: prevenire il tumore intervenendo direttamente sulla mutazione genetica che ne aumenta il rischio, grazie a una tecnologia già impiegata con successo in altre malattie rare come la SMA e la distrofia di Duchenne, ma mai applicata prima all’Anemia di Fanconi.
Intervista a cura della Direzione Scientifica - Direttore Scientifico Prof. Massimo Zeviani grazie al supporto della dott.ssa Lorenza Masè. Si ringrazia per le foto la dott.ssa Denise Zerjal.


Dott.ssa Faleschini, come è nata l’idea del progetto? Perché proprio l’anemia di Fanconi?
Perché è una malattia rara, complessa, e ancora senza una terapia farmacologica mirata. L’idea è nata qualche anno fa assieme ad una collega, la dott.ssa Roberta Bottega, con cui abbiamo lavorato tanti anni sulle basi molecolari di questa malattia. Più studiavamo l’Anemia di Fanconi, più ci rendevamo conto che c’era un grande bisogno di nuove idee, soprattutto pensando ai pazienti adulti. Oggi, grazie ai trapianti di cellule staminali, queste persone vivono più a lungo – anche oltre i quarant’anni – e questo è un risultato straordinario. Ma ha anche cambiato radicalmente lo scenario clinico: la principale causa di morte non è più l’insufficienza midollare ma nel 60% dei casi, lo sviluppo di tumori, in particolare del cavo orale e della regione anogenitale. Affrontare questa nuova sfida è fondamentale.
E AIRC ha deciso di scommettere sul suo progetto. Che valore ha questo riconoscimento per lei?
Altissimo. Il My First Grant serve proprio a questo: far crescere giovani ricercatori e renderli indipendenti. È un passaggio fondamentale, perché mi consente di creare il mio gruppo e di avere risorse, tempo e visione per lavorare su una linea di ricerca autonoma.
Ci racconta in parole semplici cos’è l’anemia di Fanconi?
È una malattia genetica rara e complessa, che coinvolge almeno 22 geni diversi – i cosiddetti geni FANC – tutti impegnati in un compito cruciale: riparare il DNA quando subisce un danno. Immaginiamo il DNA come un libro di istruzioni, scritto in milioni di pagine. Ogni giorno può succedere che alcune pagine si rovinino o si strappino. Nelle persone sane ci sono delle “squadre di manutenzione” – di cui fanno parte le proteine prodotte dai geni FANC – che sistemano subito i danni. Nei pazienti Fanconi, invece, queste squadre non funzionano bene o mancano del tutto.Il risultato è che le cellule accumulano errori. Questo porta a due problemi principali: il primo è che il midollo osseo smette gradualmente di funzionare, producendo sempre meno cellule del sangue (globuli rossi, globuli bianchi e piastrine). Si chiama insufficienza midollare e provoca anemia, infezioni ricorrenti ed emorragie. Il secondo problema è che, col tempo, questi errori nel DNA possono favorire la trasformazione tumorale. Infatti, i pazienti Fanconi hanno un rischio altissimo di sviluppare tumori, soprattutto alla testa, al collo e nella regione anogenitale. Il gene colpito più spesso, nell’80% dei casi, è il FANCA, ma ci sono molte varianti, e questo rende la malattia ancora più difficile da affrontare.
Il vostro obiettivo è proprio correggere gli effetti delle mutazioni nel gene FANCA, giusto?
Esatto. L’anemia di Fanconi è causata da mutazioni in almeno venti geni diversi, ma l’80% dei pazienti ha un difetto proprio nel gene FANCA. E di queste, circa il 20% sono mutazioni particolari chiamate mutazioni di splicing. Lo splicing è un passaggio fondamentale nel processo di “traduzione” delle istruzioni contenute nel DNA. Perché ciò avvenga, infatti, il DNA deve essere copiato in una molecola di RNA che viene successivamente tagliata e ricucita in modo preciso (splicing) per estrapolare il messaggio. Quando la mutazione interferisce con questo passaggio, il messaggio finale è sbagliato e la proteina non viene prodotta correttamente o non viene prodotta affatto. Noi ci concentriamo su queste mutazioni perché oggi abbiamo una tecnologia specifica che può intervenire direttamente lì: gli oligonucleotidi antisenso. Queste molecole si legano all’RNA proprio in corrispondenza del difetto di splicing e lo “mascherano”, cioè impediscono che venga letto come un errore. In questo modo, la cellula riesce a completare correttamente il montaggio dell’RNA e a produrre una proteina funzionante.
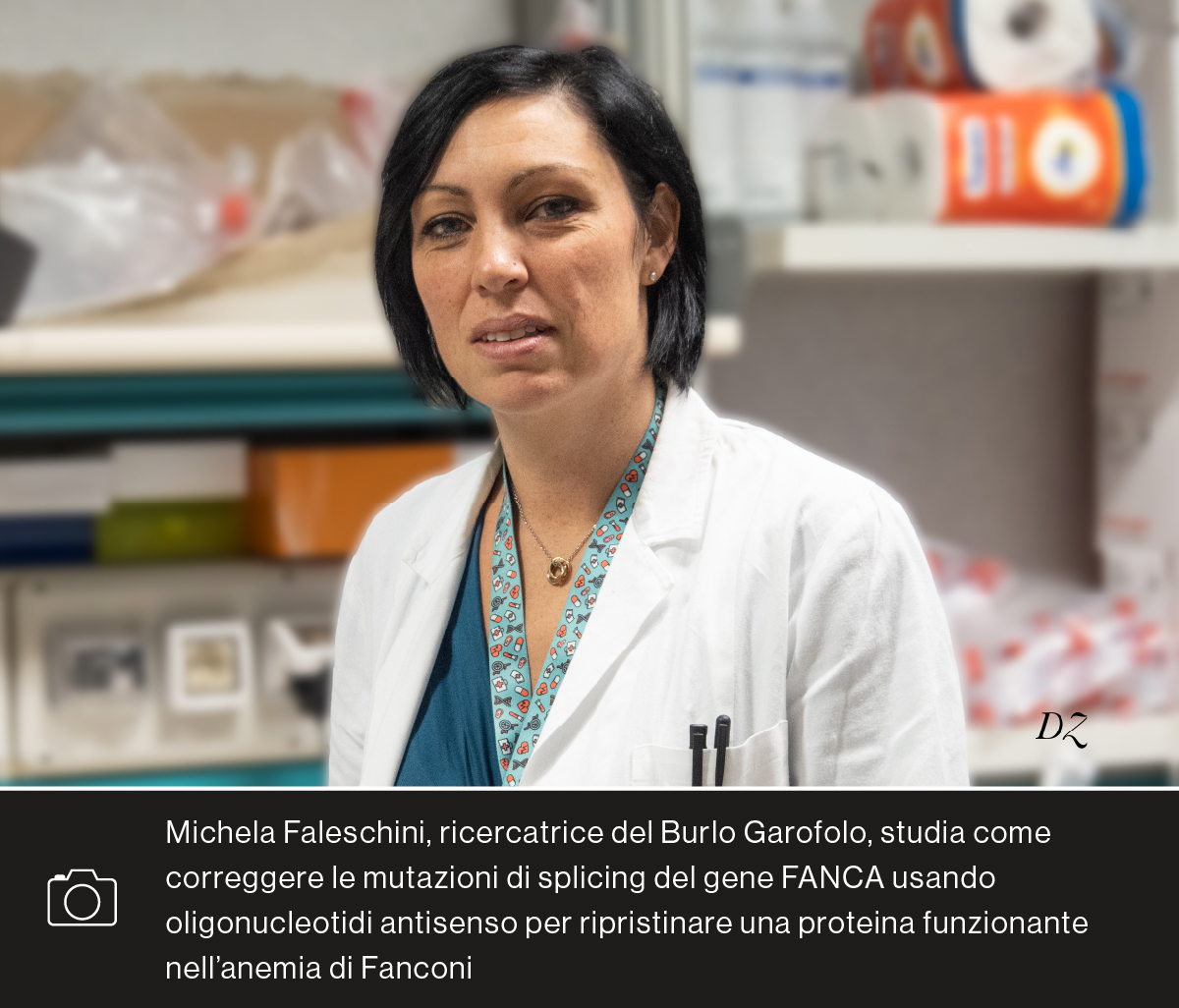
Questa tecnologia è già in uso clinico?
Sì, per altre malattie genetiche rare. Il caso più famoso è quello dell’atrofia muscolare spinale (SMA), trattata con il farmaco Spinraza, ma anche la distrofia di Duchenne. In entrambi i casi, l’approccio ha portato a risultati clinici molto significativi. Va anche detto che nel caso della SMA è necessario che gli oligonucleotidi superino la barriera ematoencefalica per raggiungere i motoneuroni, il che rende la somministrazione più complessa. Nell’anemia di Fanconi, invece, non ci sono barriere di questo tipo: dobbiamo colpire tutte le cellule, ma l’accessibilità è maggiore. Questo rende l’applicazione potenzialmente più semplice, almeno da un punto di vista tecnico.
Qual è la novità del vostro progetto rispetto a questi esempi?
La novità è usare gli oligonucleotidi antisenso per la prima volta nell’Anemia di Fanconi, che è più sistemica e con implicazioni oncologiche importanti. Se riusciamo a ripristinare la funzione del gene coinvolto nella riparazione del DNA, possiamo ridurre l’accumulo di danni genetici e riportare il rischio tumorale ai livelli della popolazione generale. I prossimi anni saranno cruciali per confermare questi risultati in modelli animali e, speriamo presto, arrivare a una sperimentazione clinica.
Quindi una terapia farmacologica vera e propria, non solo prevenzione?
Esatto. Fino a oggi, anche per quanto riguarda i tumori, si è potuto fare poco più che organizzare controlli frequenti: visite programmate, screening ravvicinati, in alcuni Paesi anche strumenti digitali come app basate sull’intelligenza artificiale per l’auto-monitoraggio delle lesioni nel cavo orale – visto che lì si sviluppano molti dei tumori. Ma tutto questo è sorveglianza, non è cura.
Il nostro progetto vuole cambiare prospettiva: prevenire il tumore intervenendo sulla causa molecolare che lo rende così probabile nei pazienti Fanconi. È questo l’aspetto più innovativo.
Quali sono i prossimi passi?
Abbiamo cominciato a gennaio 2025. Abbiamo già dimostrato che il sistema funziona in vitro: cioè, nei modelli cellulari, gli oligonucleotidi antisenso riescono a correggere il difetto di splicing e a ripristinare la produzione della proteina corretta.
Ora stiamo lavorando su cellule dei pazienti e su modelli animali. È un lavoro lungo, ma l’obiettivo è chiaro: arrivare, tra cinque anni, con dati abbastanza forti da proporre una sperimentazione clinica. Vogliamo dimostrare che si può passare dal laboratorio alla cura.
Chi collabora con voi?
Collaboriamo con l’Università di Bari per la parte di sperimentazione in vivo, l’altra collaborazione chiave è con l’Istituto Gaslini di Genova, che è il centro di riferimento nazionale per l’anemia di Fanconi. Loro ci aiutano a individuare le mutazioni presenti nei pazienti, e questo è cruciale perché ogni oligonucleotide antisenso va disegnato su misura, per una specifica mutazione.
Nel nostro progetto iniziamo con una mutazione “pilota”, ma l’idea è che questa strategia, se funziona, possa essere estesa ad altre mutazioni. Per farlo, dobbiamo sapere quali sono le più frequenti, le più problematiche, e lì il Gaslini ha un ruolo fondamentale.
Un’ultima domanda: questa terapia potrebbe funzionare anche per altre malattie?
Potenzialmente sì. Gli oligonucleotidi antisenso sono già una realtà in altre patologie genetiche, soprattutto neurodegenerative, come la SMA e la distrofia muscolare di Duchenne.
Se riuscissimo a dimostrare l’efficacia di questa tecnologia anche in un contesto più sistemico come l’Anemia di Fanconi – che coinvolge il sangue, il sistema immunitario, il rischio oncologico – potremmo aprire la strada a nuove applicazioni. I mezzi li abbiamo: ora si tratta di usarli anche dove finora non ci siamo spinti.