Intervista al Prof. Valerio Carelli, responsabile della Neurogenetica dell’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna e professore ordinario di Genetica Medica all’Università di Bologna
Ci sono malattie che nascono nei luoghi più profondi della cellula: le malattie mitocondriali, per anni considerate solo un problema di “batterie scariche”, oggi raccontano una storia molto più complessa — fatta di infiammazione, microangiopatie e segnali di pericolo che si diffondono nel corpo come un SOS.
Il Prof. Valerio Carelli, del Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie dell’Università di Bologna, tra i massimi esperti internazionali di genetica mitocondriale, ci guida in un viaggio al centro della cellula, per capire come il DNA dei mitocondri possa accendere o spegnere interi circuiti di salute. Una lezione che unisce ricerca di frontiera e prospettive terapeutiche concrete, e che ci invita a guardare i mitocondri non più come semplici centrali energetiche, ma come i veri sensori vitali delle nostre cellule.
Articoli a cura della Direzione Scientifica - Direttore Scientifico Prof. Massimo Zeviani grazie al supporto della dott.ssa Lorenza Masè.

Professor Carelli, qual è l’origine genetica delle malattie mitocondriali?
Per molto tempo abbiamo pensato che le malattie mitocondriali come la LHON si trasmettessero solo per via materna. I mitocondri, infatti, hanno un proprio DNA, che ereditiamo esclusivamente dalla madre attraverso la cellula uovo.
Oggi però sappiamo che la realtà è più complessa. Oltre alle mutazioni nel DNA mitocondriale, esistono infatti molte alterazioni in geni del DNA nucleare — circa 1200 o forse più — che regolano il corretto funzionamento dei mitocondri.
Quando questi geni si modificano, anche i mitocondri ne risentono, e possono comparire le stesse patologie. In questi casi, la trasmissione segue le regole classiche della genetica: può essere dominante, recessiva o legata al cromosoma X.
In sintesi, le malattie mitocondriali possono avere una doppia origine: materna, se la mutazione è nel DNA dei mitocondri, o “classica”, se è nel DNA del nucleo — a seconda del gene coinvolto.
Professor Carelli, nella sua lezione ha detto che le malattie mitocondriali non sono solo un problema di energia. Cosa intendeva?
Nella visione convenzionale si è pensato che il problema fosse tutto lì: nei mitocondri che non producono abbastanza ATP, cioè la molecola che fornisce energia alle cellule.
Ma oggi vediamo un quadro molto più articolato. Queste malattie non riguardano solo un deficit energetico, ma coinvolgono anche infiammazione, stress ossidativo e problemi ai vasi sanguigni.
E soprattutto, non si manifestano con un lento declino, come accade di solito nelle malattie neurodegenerative classiche: qui parliamo di eventi acuti, spesso catastrofici, che si sviluppano nel giro di poche settimane.
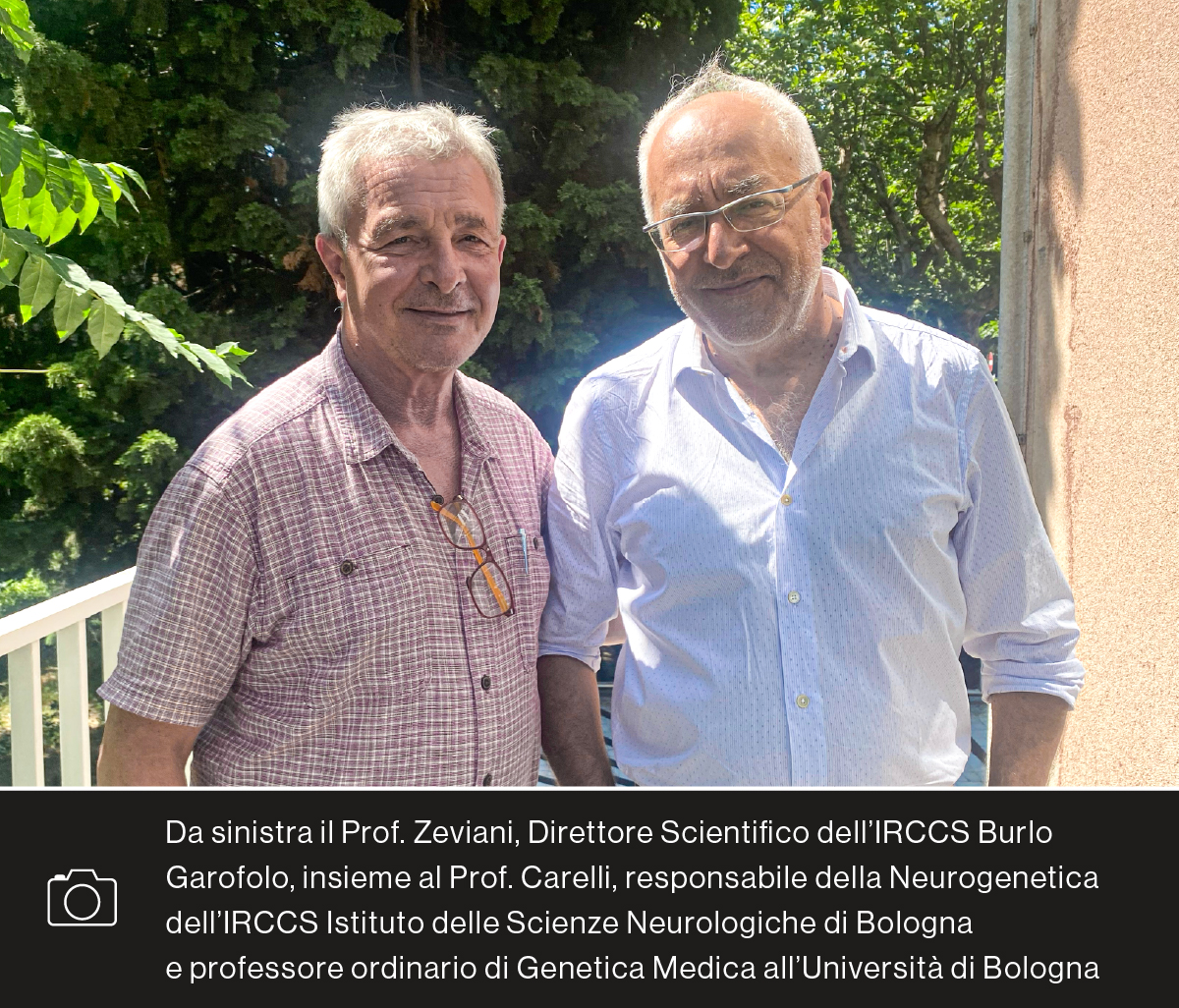
Ci può fare qualche esempio concreto di come si manifestano alcune malattie mitocondriali?
Prendiamo tre sindromi classiche: LHON, MELAS e Leigh.
Sono molto diverse nei dettagli clinici, ma hanno una caratteristica comune: si manifestano in modo improvviso e drammatico.
Una persona può perdere la vista in pochi giorni nella LHON, un’altra può avere crisi epilettiche molto intense, un’altra ancora subire danni cerebrali nel giro di poche settimane come nelle sindromi MELAS e Leigh.
Non c’è un declino lento, come nelle malattie neurodegenerative più note: qui tutto accade rapidamente, ed è spesso catastrofico.
Cosa accomuna queste malattie così diverse?
In tutte osserviamo un coinvolgimento dei piccoli vasi sanguigni, che potrebbe spiegare la rapidità e la gravità con cui la malattia evolve.
C’è poi un fenomeno particolarmente interessante: il rilascio del DNA mitocondriale fuori dalle cellule.
Questo DNA libero viene riconosciuto dal sistema immunitario come un segnale di pericolo e scatena una forte risposta infiammatoria.
Perché questo è importante dal punto di vista terapeutico?
Questi elementi — infiammazione, stress ossidativo, danno vascolare, rilascio di DNA — che un tempo consideravamo secondari, oggi li vediamo come protagonisti nel peggioramento della malattia.
E rappresentano anche nuovi bersagli terapeutici, su cui possiamo intervenire con strategie sempre più mirate.
Professor Carelli, quali sono oggi le principali linee di ricerca nel suo laboratorio?
In questo momento stiamo lavorando proprio su questo approccio — il repurposing, cioè l’utilizzo di farmaci già esistenti per nuovi scopi terapeutici.
È una strategia che accelera la ricerca, perché si basa su molecole di cui conosciamo già il profilo di sicurezza.
Per esempio, stiamo sperimentando la rapamicina per trattare la sindrome MERRF, una grave malattia mitocondriale.
Ma non ci fermiamo qui: stiamo anche esplorando nuove combinazioni di molecole e terapie che possano agire su quei meccanismi infiammatori e vascolari.
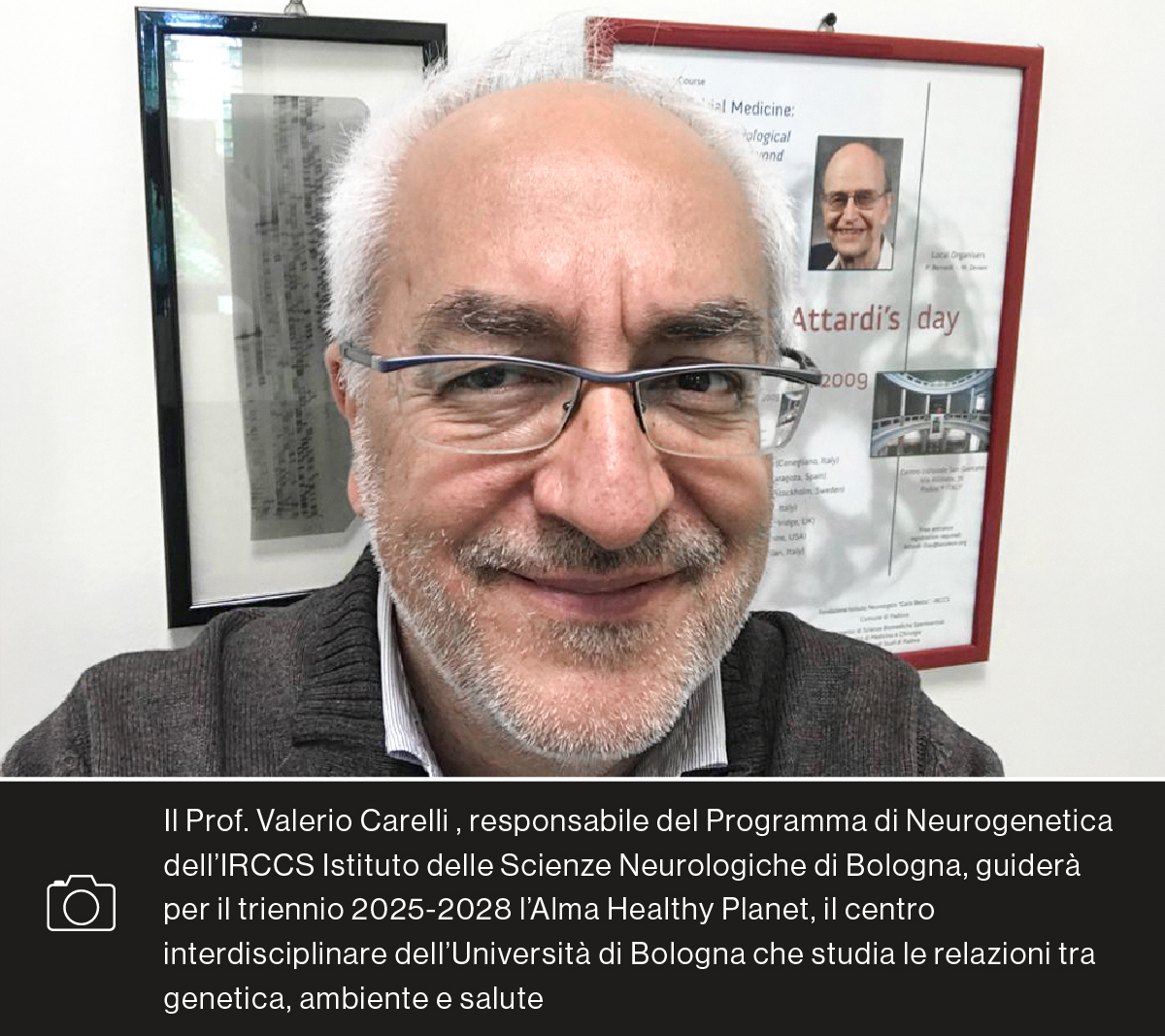
Che cosa possiamo aspettarci nel prossimo futuro per le terapie?
Stiamo entrando in una fase nuova e molto promettente.
Accanto al repurposing, che ci permette di usare in modo intelligente farmaci già noti, stanno arrivando tecnologie davvero rivoluzionarie, come l’editing genetico dei mitocondri.
Parliamo di strumenti capaci di correggere il DNA mitocondriale alterato, eliminare le molecole mutate e favorire quelle sane.
È un approccio ancora sperimentale, ma i progressi degli ultimi anni sono notevoli: stiamo passando dall’idea alla pratica.
I tempi della ricerca traslazionale sono lunghi, ma i primi segnali positivi arrivano già dagli studi clinici: il futuro sarà fatto di terapie sempre più mirate, personalizzate e integrate, capaci di agire non solo sui sintomi, ma sulle cause stesse della malattia.
Le scoperte fatte sulle malattie mitocondriali possono essere utili anche per altre patologie?
Assolutamente sì.
Le malattie mitocondriali sono rare, ma ci insegnano moltissimo su meccanismi biologici che ritroviamo anche in patologie più comuni — dal Parkinson al diabete, fino a molte forme di infiammazione cronica.
Capire come si ammala il mitocondrio significa capire meglio anche come si ammala la cellula.
In fondo, i mitocondri sono un po’ come le “scatole nere” del nostro corpo: raccontano cosa accade dentro di noi, e studiarli ci aiuta a mantenerci in salute più a lungo.


