Il Burlo a Trieste Next.
Intervista al prof. Guido Barbujani, genetista e autore di L’alba della storia (Laterza)
Per secoli la preistoria è rimasta un grande silenzio. Poi è arrivato il DNA, e ha cominciato a parlare.
Oggi i genetisti riescono a leggere nelle nostre cellule un racconto che attraversa millenni: quello delle popolazioni che si sono incontrate, mischiate, cambiate.
Tra i protagonisti di questa rivoluzione c’è il Prof. Guido Barbujani, genetista dell’Università di Ferrara, ospite del Burlo Garofolo per una keynote lecture riservata ai ricercatori e una conferenza aperta al grande pubblico nell’ambito di Trieste Next 2025.
Con lui abbiamo parlato di agricoltori del Neolitico, mutazioni che ci hanno insegnato a bere latte e, a sorpresa, di eroi omerici con la pelle scura.
Intervista a cura della Direzione Scientifica - Direttore Scientifico Prof. Massimo Zeviani grazie al supporto della dott.ssa Lorenza Masè. Si ringrazia per le foto la dott.ssa Denise Zerjal.

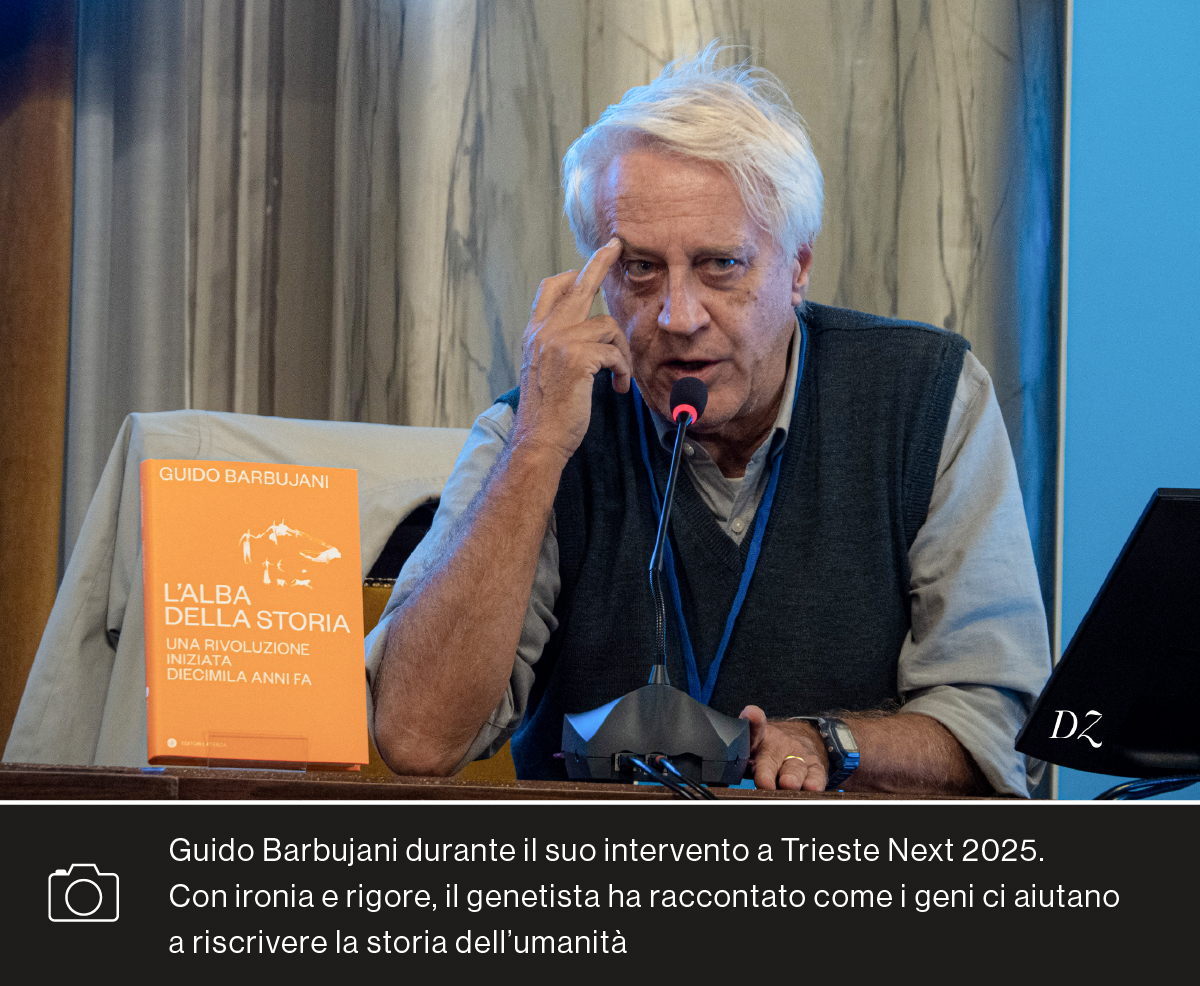
Professor Barbujani, qual è stata la scoperta più sorprendente di questi anni?
Direi quella del 1978, quando Luca Cavalli Sforza capì che nel nostro DNA è conservato un messaggio dal passato, trasmesso di generazione in generazione.
Se sappiamo leggerlo, ci racconta storie di cui non esistono documenti: migrazioni, incontri, mescolanze.
Da lì è nato un nuovo settore della genetica delle popolazioni, che prova a interpretare i segni lasciati dall’evoluzione nella nostra storia.
E la possibilità di leggere il DNA antico, che cosa ha cambiato?
È stata una rivoluzione. Da alcune ossa fossili — non tutte, ma le più recenti — si può estrarre DNA in buono stato.
Confrontando i genomi antichi con quelli moderni, abbiamo cominciato a vedere come le popolazioni sono cambiate, si sono spostate e incrociate nel tempo.
È come se la preistoria, da ipotesi, fosse diventata racconto.
Che cosa ci dice il DNA sul Neolitico, il momento in cui nasce l’agricoltura?
Circa 11.000 anni fa, dall’Anatolia, si diffondono in Europa agricoltura e allevamento.
Cavalli Sforza notò che la mappa genetica degli europei somiglia a quella della diffusione dell’agricoltura: segno che non si trattò solo di idee che viaggiavano, ma di persone.
Fu una grande migrazione di contadini e allevatori. Il nostro DNA, oggi, è il risultato di quelle antiche mescolanze con i primi europei arrivati dall’Africa.

Nel suo libro parla spesso di meticciato. Che cosa intende?
Il meticciato è la regola della nostra specie.
Un grande studio recente mostra che nel Paleolitico le popolazioni anche a pochi chilometri di distanza erano molto diverse geneticamente: vivevano isolate. Poi, con il crescere della densità umana, le differenze si riducono.
Già all’età del bronzo le popolazioni europee si somigliano molto fra loro.
Non significa che siamo tutti uguali, ma che ogni popolazione contiene un campionario dei geni di tutte le altre.
È curioso: proprio quando nascono le prime città, la mobilità aumenta invece di ridursi. La storia dell’uomo è una storia di viaggi, non di confini.
E la pelle chiara? È davvero un tratto antico degli europei?
Tutt’altro. Fino a 10.000 anni fa, gli europei avevano in media pelle scura.
L’“Uomo di Cheddar”, vissuto in Inghilterra, aveva pelle scura e occhi azzurri. Lo stesso vale per altri individui trovati in Spagna, Svizzera e Lussemburgo.
Con l’arrivo degli agricoltori dall’Anatolia comparvero pelle chiara e occhi scuri, ma il cambiamento fu lento: fino all’Età del ferro — ai tempi della guerra di Troia e della fondazione di Roma — metà Europa aveva ancora la pelle scura.
Gli “eroi omerici”, insomma, probabilmente non erano tutti come li immaginiamo oggi.

E poi c’è il latte: anche quello è una traccia genetica.
Sì. Alla nascita tutti produciamo lattasi, ma in passato il gene si spegneva dopo lo svezzamento.
Con l’allevamento, chi per “errore” continuava a produrla da adulto aveva un vantaggio: poteva bere latte e mangiare formaggi.
Quelle mutazioni, comparse circa 9.000 anni fa, si sono diffuse rapidamente in Europa e in Africa.
È un esempio perfetto di coevoluzione tra cultura e biologia: abbiamo addomesticato gli animali, ma in un certo senso anche loro hanno addomesticato noi.
La genetica cambia anche il modo in cui pensiamo le identità?
Sì. Il DNA non dice chi siamo, ma ci ricorda da dove veniamo: da un processo continuo di mescolamento.
Le popolazioni non sono mai state isolate. La genetica mostra che la diversità è naturale, e che la somiglianza tra gli esseri umani è enorme.
È una scienza, direi, profondamente antirazzista: nella nostra specie i confini biologici semplicemente non esistono.
E nella medicina, cosa ci insegna questa storia?
Che capire la nostra evoluzione aiuta a capire come funziona il corpo umano.
Il Nobel 2022 a Svante Pääbo, per i suoi studi sul DNA antico, lo dimostra.
Ma la genetica ha anche limiti: sulle malattie complesse pesano molti geni e fattori ambientali, difficili da distinguere.
Ci aiuta però nella medicina personalizzata: non serve conoscere la media di una popolazione, ma come quel singolo individuo reagisce a un farmaco.
In una frase, che cosa ci insegna il DNA sulla storia umana?
Che la nostra storia è una storia di incontri.
Ogni volta che abbiamo provato a isolarci, abbiamo solo rallentato un processo che ci unisce da sempre.
Il nostro passato comune — fatto di scambi, migrazioni e meticciato — è la cosa più antica che abbiamo in comune.



